Brix: l’Albana si fa progetto tra identità e territorio
Racconti dalle delegazioni
10 luglio 2025

Una serata dedicata a un nuovo progetto che valorizza l’albana di Brisighella e tutto il suo territorio. In AIS Monza e Brianza, Davide Gilioli, degustatore e relatore AIS, Paolo Babini vicepresidente dell’Associazione “Brisighella, Anima dei Tre Colli” e titolare di Vigne Bosch e Alexis Camprini titolare di Les Galèts, hanno raccontato il progetto Brix.
RUBRICHE
Davide Gilioli ha conquistato una sala attenta con il suo racconto avvincente dedicato a un vitigno ancora troppo poco valorizzato: l’albana. Non solo ha saputo spiegare con competenza le peculiarità di questa varietà, ma ha anche intrecciato il racconto con frammenti personali, coinvolgendo il pubblico in un viaggio intimo ed entusiasmante. «Ho incontrato Paolo [Babini] per la prima volta in un ristorante a Carpi», racconta Davide con un sorriso. «Mi colpì subito con vini fuori dagli schemi: un Pagadebit macerato, un fortificato battezzato Bagnol, etichette sperimentali, sempre diverse, spesso irripetibili. Intuii subito che dietro quelle bottiglie si nascondeva una mente irrequieta e geniale, capace di fondere rigore, intuizione e una sana dose di follia creativa. Da lì è nata la nostra amicizia». Oggi Paolo Babini lavora con dedizione su vitigni autoctoni e internazionali: albana, sangiovese, trebbiano, ma anche riesling e sauvignon. È uno dei protagonisti di un progetto audace e visionario: restituire all’albana un’identità nuova e profonda, attraverso zonazione, selezione e rispetto del territorio. Un lavoro meticoloso che punta a creare un vero cru nel cru, riscrivendo il futuro di questo vino con passione e consapevolezza.
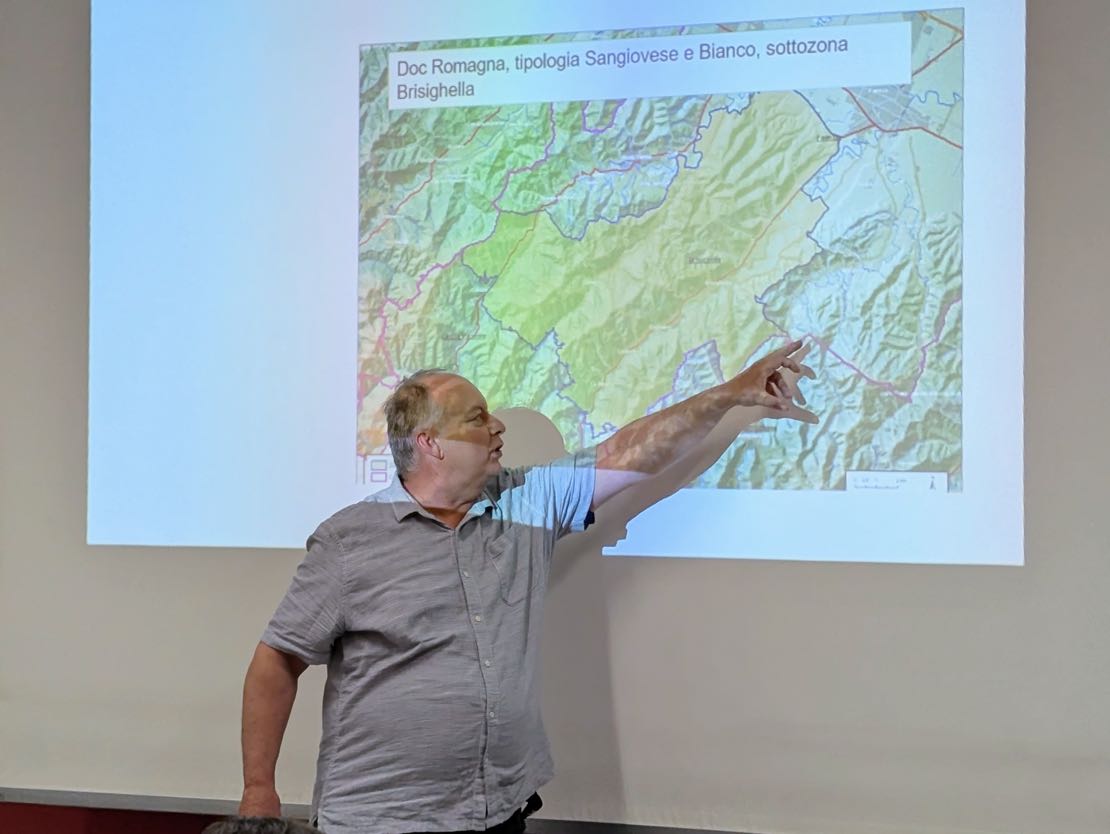
Tra storia, leggenda e rinascita
Un vitigno dalla personalità decisa, dalla buccia spessa, ricca di tannini, con acidità vertiginosa e una struttura che ricorda più un rosso che un bianco. Non a caso, l’albana è stata spesso definita «un rosso travestito da bianco». La leggenda racconta che fu proprio un calice di questo vino a far rinvenire Galla Placidia dopo una caduta da cavallo, episodio che contribuì a renderla celebre come bevanda “da nozze” e persino “da Messa”.
Nel 1987 fu la prima varietà bianca italiana a ottenere la DOCG. Un traguardo prestigioso, ma seguito da decenni di incertezze: vinificazioni dolci, letture rustiche, poca precisione in vigna e in cantina. Il trebbiano, con la sua resa elevata e docilità, l’ha oscurata per lungo tempo. Anche nella memoria familiare, l’albana era vino da damigiana: o passito, o spigoloso. Eppure, oggi qualcosa è cambiato. Alcuni vignaioli hanno scelto di crederci davvero, di esplorarne i biotipi, di lavorare sulla zonazione, sul dialogo profondo tra suolo e pianta. L’albana, infatti, reagisce con sensibilità straordinaria ai terreni, al clima, alla mano di chi la coltiva. E questo rende ogni bottiglia unica, ogni vendemmia una nuova scommessa.
Esistono almeno tre biotipi principali di albana, che riassumono la varietà e la ricchezza genetica della specie. L’albana lunga, dai grappoli imponenti, si sviluppa bene su suoli argillosi, come quelli dell’imolese o della zona della Serra. L’albana media, tipica di Brisighella, cresce su terre miste di marne e calcari, e offre maggiore equilibrio. L’albana corta, detta anche “gentile”, è legata a Bertinoro, dove i terreni calcarei, più magri, impongono alla vite una concentrazione maggiore, regalando vini sottili e aromatici.
Un equilibrio essenziale
Vinificare l’albana non è cosa semplice. Richiede attenzione estrema, sensibilità tecnica, pazienza. Vendemmiarla troppo presto significa accentuarne l’acidità naturale; raccoglierla tardi espone al rischio di alcolicità eccessiva. In passato era comune la macerazione sulle bucce, mentre oggi si va spesso verso vinificazioni più essenziali, capaci di far emergere la purezza varietale. L’uso del legno è delicato: serve a modulare la potenza, non a sovrastarla.
Accanto alla versione secca, resta affascinante – seppur rara – quella dolce ottenuta da uve botritizzate. Un tempo era il fiore all’occhiello della denominazione, grazie alla concentrazione naturale e ai profumi intensi donati dalla Botrytis cinerea. Oggi, con i cambiamenti climatici, queste espressioni diventano sempre più difficili da ottenere, ma restano veri gioielli da custodire. Questa diversità, pur concentrata in una zona geografica limitata, conferma quanto l’albana sia sensibile al terroir e meritevole di una vinificazione mirata, che ne esalti davvero il potenziale.

Il progetto BRIX
Tra le colline di Brisighella, uno dei borghi più affascinanti dell’Appennino romagnolo, prende vita il progetto Brix. Il nome affonda le radici nella lingua celtica - bric, “luogo scosceso” - da cui deriva anche il toponimo stesso di Brisighella (così come quello di Brescia, nata anch’essa su un colle). Nel 2011, diciannove produttori uniscono le forze e fondano l’associazione Brisighella, Anima dei Tre Colli, con l’obiettivo di valorizzare l’albana in purezza, elevandone la qualità attraverso un disciplinare più severo rispetto alla stessa DOCG. Le regole sono chiare: rese più basse, vinificazioni rispettose del territorio, affinamenti più lunghi e curati.
Nasce così un progetto corale, ambizioso e identitario, che ha trasformato la sottozona di Brisighella in un vero laboratorio enologico a cielo aperto.
Il territorio è un mosaico geologico di rara complessità, dove suoli diversissimi si susseguono in pochi chilometri, influenzando in modo diretto e riconoscibile il profilo dei vini. Tre le principali macroaree individuate:
- la zona argillosa, come quella che circonda la Torre dell’Orologio, regala albane strutturate e longeve, capaci di evolvere magnificamente nel tempo;
- l’area gessosa, nei dintorni della Rocca Manfrediana, dà vita a vini tesi, salini, dalla spiccata impronta minerale;
- l’alta collina del Monticino, su suoli di marne e arenarie, è invece la culla di vini eleganti, sottili e taglienti, che uniscono finezza aromatica e precisione gustativa.
Il lavoro di zonazione è portato avanti con l’aiuto delle università di Bologna e Milano. A settembre sarà presentata una nuova mappa dei cru, un passo importante per dare ancora più identità a questa zona che ha tutte le carte in regola per diventare punto di riferimento per l’albana di qualità. Il progetto BRIX, inizialmente pensato anche per il sangiovese, si è rapidamente concentrato sull’albana, varietà che a Brisighella rappresenta ormai quasi il 23% della produzione totale romagnola. Un patrimonio che si sta arricchendo grazie a nuovi impianti, alla partecipazione dei giovani e alla volontà comune di costruire qualcosa di duraturo.
Il disciplinare condiviso prevede vinificazione in bianco con breve macerazione pre-fermentativa, affinamento minimo di sei mesi in legno piccolo (a bassa tostatura) e sei mesi in bottiglia. L’uscita sul mercato è fissata a due anni dalla vendemmia, con lancio congiunto. Ma ciò che rende BRIX un progetto speciale è anche l’approccio collettivo: l’associazione è aperta a tutti i vignaioli della zona che vogliano aderire al disciplinare. Nessuna selezione d’élite, solo regole condivise e confronto costante. Non mancano le uscite, quando serve: due aziende hanno lasciato il gruppo nel 2022, con onestà e rispetto, perché non si riconoscevano più nel percorso intrapreso. Questa trasparenza è la forza di un progetto che vuole essere solido e duraturo, non solo qualitativamente, ma anche economicamente. Per questo è stato introdotto anche un prezzo minimo di vendita: una scelta coraggiosa, ma necessaria, per superare l’etichetta del vino romagnolo “buono e basta”, e affermare un’identità di valore, cultura e longevità.
La degustazione
L’annata 2022, in degustazione durante la serata, è la prima. La 2023 uscirà a settembre, con un numero ancora maggiore di aziende coinvolte. Paolo Babini è uno dei protagonisti, con un’albana che unisce struttura e finezza, maturità e vitalità. Il biotipo coltivato a Brisighella, meno ricco in polifenoli rispetto ad altri, si presta bene a una lettura più elegante, pensata per l’evoluzione nel tempo.
Sillaro IGP “Scorzonera Brix” 2022 - Azienda Agricola Bulzaga
100% albana. Vinificazione in acciaio e affinamento 12 mesi in barrique di primo e secondo passaggio, a tostatura leggera. L’azienda, fondata nel 2009 da Alessandro Bulzaga, si trova a circa 200 metri s.l.m. nella zona bassa, su suoli prevalentemente argillosi. Il nome Scorzonera è un tributo poetico al paesaggio dei calanchi: terreni lunari, scavati dal tempo, dove cresce solo un piccolo fiore resistente, appunto la scorzonera. Una metafora perfetta per questa albana: forte, resistente, capace di bellezza anche in condizioni estreme.
Il colore è il primo indizio: un oro pieno, vivo, che racconta già nel calice la ricchezza dell’albana. La trama glicerica e la struttura polifenolica sono subito evidenti: roteando il vino nel bicchiere, si percepisce una materia densa, viva, quasi tattile. Al naso l’approccio è generoso, avvolgente. Provenendo da una delle fasce più basse della denominazione, prossima alla pianura, esprime tutta la pienezza del frutto maturo: albicocca, ma anche pesca gialla, susina, cenni tropicali di mango e polpa gialla esotica. Accanto a questi, una delicata scia floreale: camomilla, ginestra, fiori di campo che si intrecciano a sottili accenni di erbe officinali. Chiude il profilo olfattivo una vivace nota agrumata: scorza di pompelmo, buccia di limone, mandarino. In bocca si conferma un vino pieno, avvolgente, con una grande coerenza tra naso e palato. La struttura è solida ma equilibrata: la freschezza acida bilancia le morbidezze gliceriche e l’alcolicità, mentre il tannino, ben integrato, affiora sul finale con un tocco leggermente speziato, quasi piccante, che ricorda lo zenzero o il pepe bianco. Un vino che lascia la bocca pulita, fresca, con un finale lungo, leggermente mentolato, che invita a un nuovo sorso.
…
Una nota sul Metodo Classico: l’albana, grazie alla sua acidità, potrebbe sembrare un candidato interessante per la spumantizzazione, ma la sua natura tannica, dovuta all’elevata presenza di polifenoli, la rende una varietà complessa da gestire con successo in bollicina. Qualche esperimento esiste – anche una versione dolce con residuo zuccherino – ma la sua vera vocazione, secondo Gilioli, resta quella ferma, dove può esprimere profondità, complessità e territorio.
Romagna DOCG Albana Secco “Farfarello Brix” 2022 - Poggio della Dogana
100% albana. Vinificazione metà uve in acciaio e metà in barrique con un affinamento successivo di 9 mesi sulle fecce fini, grazie a un bâtonnage settimanale che ne arricchisce la struttura. L’azienda, fondata nel 2017 dai fratelli Aldo e Paolo Rametta, insieme a Cristiano Vitali, si trova su un crinale che segna il confine tra Modigliana e Brisighella, da cui il nome (Dogana). Il vino nasce su terreni sabbiosi, dalle sfumature giallo ocra, tra i 200 e i 300 metri di altitudine; le vigne hanno una ventina d’anni. Ogni vino dell’azienda porta il nome di uno dei cavalli da corsa appartenuti al precedente proprietario del podere: un omaggio affettuoso, che aggiunge carattere e memoria.
Questo vino proviene da vigneti molto vicini al primo ed è quindi naturale un confronto.
A livello visivo, la famiglia cromatica è la stessa: il color oro è sempre protagonista, lucente, vivo, con una consistenza importante. Il naso, rispetto al primo vino è molto diverso. Qui il profilo aromatico si fa più erbaceo, emergono note di erbe amare, di tarassaco in fiore. Questo accenno quasi incuriosisce e sorprende con sentori di decotto, infuso, radici officinali. In secondo piano, più nascosta ma presente, affiora una frutta meno esuberante: agrumi, o meglio l’albedo che pizzica il naso e lo stimola. All’assaggio, il vino si rivela subito deciso, schietto, di grande energia. È meno accomodante rispetto al primo calice: l’acidità è più marcata, le durezze più evidenti, e sul finale compare un tannino più grintoso, che si fa sentire con una leggera ruvidità sul centro bocca. Il finale è asciutto e torna quella nota amara – arancia amara, liquirizia, un soffio mentolato – che lo rende profondamente dissetante. Il risultato è un Albana fuori dal coro: più affilato, più riflessivo, ma anche di grande fascino. L’abbinamento a tavola deve essere equilibrato: le morbidezze del piatto devono compensare le asperità del sorso. Gilioli propone: «Un risotto mantecato, magari al taleggio, o dei cappelletti romagnoli in brodo: piatti morbidi, avvolgenti, ma con un tocco di grassezza e dolcezza per bilanciare l’amaro del vino, ma anche una piadina con lo squacquerone. Ma senza rucola! Quella c’è già nel bicchiere!».

Romagna DOCG Albana Secco “Corallo Giallo” 2022 - Cantina Gallegati
100% albana. Fermentazione in acciaio con 8 giorni di macerazione sulle bucce. Affinamento per 6-8 mesi in acciaio prima dell’imbottigliamento. La cantina Gallegati - fondata nel 1996 dai fratelli Cesare e Antonio Gallegati (il primo è anche presidente dell’associazione) - si trova sui primi rilievi appena sopra Faenza, nella zona dei Monti Coralli, a un’altitudine compresa tra i 150 e i 200 metri s.l.m. Il paesaggio è collinare e i suoli di base argilloso-calcarea, color ocra, conferiscono forza e struttura ai vini. Le vigne di albana hanno più di 50 anni: un patrimonio vegetale importante, che regala uve concentrate, intense, ricche di energia.
Questo calice e il prossimo sono della stessa cantina: un racconto di famiglia, di territorio e di due interpretazioni dell’albana. Stessa annata, stesso vitigno, stesso produttore, cambia solo il metodo.
Nel calice il vino è dorato, luminoso e ha una consistenza che anticipa la struttura. Al naso, spiccano note di albicocca disidratata, buccia d’arancia, camomilla, timo limone. Una punta di tè verde e nocciola fresca introduce la parte più tannica, che sarà evidente anche in bocca. Il profilo è vibrante, aromaticamente ampio, ma sempre coerente. All’assaggio la chiave di lettura è l’equilibrio tra morbidezza glicerica, acidità agrumata e tannino. Il sorso è ampio, materico. La trama tannica regala profondità, lasciando la bocca asciutta, pulita, pronta per il secondo sorso. È un’albana che sta bene in solitudine, ma che a tavola trova il suo regno.
Romagna DOCG Albana Secco “Corallo Oro Brix” 2022 - Cantina Gallegati
100% albana. Fermentazione in barrique, dove il vino sosta per 6-8 mesi, a contatto con le fecce fini.
La scelta di vinificare anche in legno nasce dal desiderio di dare longevità e prospettiva evolutiva al vino. Ed è proprio questo che esploriamo nel quarto calice: stessa uva, stessa vendemmia, ma secondo i criteri del Progetto Brix, con affinamento in botte.
Il colore è leggermente più carico, più intenso, con riflessi dorati più profondi rispetto al precedente. Al naso, si percepisce subito una leggera ossidazione elegante del frutto: mela - che comincia a scurirsi - pesca sciroppata, mango e ananas, e poi un’evoluzione verso la frutta secca: mandorla, una nocciola tostata appena accennata. Il legno c’è, ma accompagna, non sovrasta. «Dona profondità, una voce in più». In bocca, invece, la sorpresa: il vino sembra ancora più giovane, ancora più vivo. L’acidità è vibrante, agrumata, in grande spinta. Più espressiva della versione in acciaio. La chiusura è lunga, con un accenno speziato di zenzero candito, pepe bianco, e una scia balsamica che rinfresca il palato.
Sillaro IGP “AlbAgnese” 2022 - Azienda Agricola Casadio
100% albana. Fermentazione in acciaio con 4 giorni di macerazione sulle bucce; seguita da un affinamento articolato: dieci mesi in barrique usate e sei mesi in acciaio. Le vigne si trovano nella zona dei Gessi (Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola) a circa 400 metri di altitudine, una delle più elevate tra quelle presentate stasera. La vigna è relativamente giovane - ha solo dieci anni - ma poggia su un suolo gessoso-calcareo di grande interesse. L’azienda è familiare e ha ricominciato a imbottigliare nel 2008, dopo anni in cui si dedicava esclusivamente alla produzione e al conferimento delle uve.
Nel calice, il vino si presenta con un giallo paglierino intenso, ma più smorzato rispetto ai precedenti: tonalità meno solare, quasi a voler già suggerire una personalità più austera. La consistenza è ottima, compatta, anticipa struttura. Al naso, la componente minerale-sulfurea emerge con nettezza senza essere invadente, quasi tufacea, figlia del gesso. Il frutto si fa più discreto, sussurrato: lime, pompelmo, una nota di uva spina, mela verde e golden acerba. Più fresco che maturo, più bianco che giallo. A fare da cornice, sentori di erbe officinali, salvia selvatica, e un accenno di salsedine. All’assaggio, l’impronta del suolo torna con forza. La nota sulfurea ritorna in retro-olfazione, lasciando una scia salmastra, quasi da ostrica fresca: una combinazione tra mare, roccia e vento. Il tannino è presente ma non invadente, ben integrato in un sorso lungo, teso, profondamente territoriale.
Navrix 2022 - Podere La Collina
100% albana. Fermentazione spontanea, maturazione in barrique e affinamento su fecce fini per quasi un anno. Il Podere La Collina, fondato da due imprenditori svizzeri nel 2002, lavora in biologico certificato nella zona di passaggio tra i terreni marnoso-arenacei e argilloso-sabbiosi, a circa 330 metri s.l.m. A firmare il vino è Miria Scarpellini, giovane enologa di grande talento, che sta portando l’azienda verso risultati sempre più interessanti.
Già dal colore si percepisce che ci si trova di fronte a un vino differente dagli altri: giallo dorato profondo, caldo, brillante, di grande vivacità. Anche la consistenza nel calice anticipa un sorso ricco, pieno, generoso. Al naso note dolci e avvolgenti di prugna gialla in confettura, albicocca disidratata, scorza d’arancia candita. Si avverte una componente di pasticceria, che richiama zucchero a velo, crema, un soffio di ricotta dolce con scorza di cedro. In bocca il vino è un piccolo affresco: l’ingresso è quasi setoso, ma poi subentra una freschezza agrumata che asciuga, ripulisce, alleggerisce. Nonostante le apparenze olfattive, il vino è perfettamente secco, la dolcezza è solo aromatica, mai zuccherina. Chiude con una spinta citrina, che rimanda al cedro candito, alla scorza di arancia amara, con una vena balsamica, quasi mentolata. Una leggera tannicità finale sostiene il sorso e lo rende estremamente gastronomico. Davide suggerisce abbinamenti audaci: dalla cotoletta farcita alla bolognese alla cucina orientale agrodolce, passando per l’anatra all’arancia o per un formaggio stagionato.
Ravenna Bianco IGT - “Monte Re Brix” 2022 - Vigne dei Boschi
100% albana. Versione Brix da vigne piantate nel 1986 poste a 380 metri s.l.m. su terreno marnoso. Fermentazione in barrique nuove, dove resta circa un anno con bâtonnage regolare. L’azienda è stata fondata nel 1989 da Paolo Babini e da sua moglie Catia. Un aspetto fondamentale di Vigne dei Boschi è l’impegno pionieristico nel biologico, certificato fin dal 1994, e l’adozione della biodinamica dal 2002, ben prima che diventasse una tendenza diffusa.
Il colore è dorato, luminoso, fitto, con una consistenza piena che si intuisce già al primo movimento. Al naso «è una passeggiata in un prato d’altura dopo un temporale estivo». Profumo di erbe balsamiche, di camomilla selvatica, di fiori gialli e di mentuccia. Sul fondo si affaccia il frutto: mela gialla, pera matura, un accenno di mandarino cinese che incuriosisce. E poi, più in profondità, cedro candito, limone, albicocca, tutto in sfumature leggere, armoniche, cesellate. In bocca, il vino è coerente, raffinato, delicato e persistente. Il sorso è ampio ma contenuto, si muove con tatto e precisione, senza sbavature. La sapidità è ben integrata, il tannino appena accennato, l’acidità precisa, che tiene tutto in equilibrio. È un vino che oggi si offre con discrezione, ma lascia intuire una profondità ancora da esplorare. Non è esplosivo: è introspettivo, elegante, composto. Una bottiglia che meriterebbe di essere riaperta tra sei o sette anni, per vedere fin dove può arrivare. Un vino da godere da solo, in una serata lenta, oppure in abbinamento con formaggi stagionati, magari a crosta lavata, o a piatti dalla struttura morbida ma dai sapori fini, come un risotto alle erbe di campo o una zuppa di cipolle caramellate.
Ravenna Bianco IGT “Monte Re” 2022 - Vigne dei Boschi
100% albana. Versione tradizionale, vinificata in acciaio. Affinamento in botti di legno grande.
Il colore è un po’ più chiaro e meno profondo del precedente. Al naso, lo stile cambia: più frutta, meno erba e meno fiori. La parte agrumata guida l’aroma, con sentori di bergamotto, arancia bionda, mela renetta. E poi una nota singolare, che richiama la cera d’api, la nocciola fresca, la mandorla ancora verde. Un accenno di miele d’acacia. All’assaggio, l’effetto è immediato: una spinta fresca, vibrante, un’acidità tagliente, netta, verticale. Il vino è più diretto, più coinvolgente sin dal primo sorso. «Dove il Brix si mostrava riflessivo, questo è solare, aperto, quasi esuberante nella sua freschezza. La bocca salivante, la tensione agrumata, il finale mentolato fanno di questa albana una compagna perfetta a tavola». In sintesi, due vini che raccontano lo stesso vignaiolo, la stessa annata, lo stesso vitigno, ma con due linguaggi diversi.

Romagna DOCG Albana Secco “Montesiepe” 2022 - Vigne di San Lorenzo
100% albana. Fermentazione e maturazione per 9 mesi in tini troncoconici aperti. L’azienda è piccola (4 ettari), il casolare stilizzato, simbolo della storia agricola e familiare di Filippo Manetti, vignaiolo verace di Brisighella, che da anni porta avanti un’idea di vino libera, solida, spesso spigolosa, ma oggi sempre più calibrata. Le vigne si trovano a circa 200 metri s.l.m. su suoli marnoso-sabbiosi.
Nel bicchiere si presenta con un giallo dorato intenso, profondo, e riflessi che richiamano la resina, l’ambra, la terra riscaldata dal sole. Il naso è potente e complesso: frutta disidratata che vira sull’albicocca secca, mela cotogna, scorza d’arancia candita. Accenni di nocciola tostata, arachide, e una sfumatura quasi ossidata che però non disturba, ma impreziosisce, regala ampiezza. «E poi c’è la resina di pino, di corteccia, con una vena di idrocarburo e malto, che ricorda certi whisky torbati a bicchiere vuoto». In bocca l’acidità è alta, quasi tagliente all’inizio, ma si armonizza via via che il sorso si ripete. Il finale è lungo, persistente, con una coda amara piacevole che ricorda il rabarbaro, le radici officinali, le erbe selvatiche. Un contrappunto continuo tra dolce e amaro, tra calore e freschezza, che rende il vino complesso, stratificato, indimenticabile. Cosa abbinarci? «Serve un piatto con la stessa forza: un formaggio di fossa di Sogliano, intenso, quasi piccante, oppure un risotto al taleggio e rosmarino, o un piatto di funghi porcini arrostiti con riduzione balsamica. Non è un vino da aperitivo: è vino da pasto, da riflessione, da confronto».
La serata si chiude con una riflessione aperta sul futuro: è il legno – grande o piccolo – una delle strade per esprimere al meglio questo vitigno? La risposta è nei calici, ma anche nei volti soddisfatti del pubblico. L’appuntamento è a settembre, per la vendemmia del 2023. Chi ha avuto la fortuna di assaggiare queste bottiglie oggi, potrà dire un giorno di esserci stato all’inizio di un nuovo cammino.